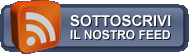Canali
Ultime news

Ultimi articoli
 Le ultime dal Forum |

Correlati TagPassa qui con il mouse e visualizza le istruzioni per utilizzare i tag!
Il pezzo che stai leggendo è stato pubblicato oltre un anno fa.
 La trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto. La trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.
Lawrence Lessig, noto "giurista informatico" autore di "Code and other laws of cyberspace", ha posto al centro dei suoi studi il code, ossia il software e l'hardware che caratterizzano la struttura intrinseca dello spazio non-reale. Il code (o architettura) altro non è che la legge del cyberspazio, in quanto è in grado di regolamentare i comportamenti ancor meglio di quanto ne sia capace la legge in senso stretto Tuttavia, mentre nel mondo reale abbiamo un'effettiva percezione di come le leggi regolino i nostri comportamenti, nel mondo virtuale risulta più difficile capire come il code incida sulle nostre azioni, dal momento che esso rimane in gran parte invisibile. Ciò nonostante, il code non deve essere percepito come qualcosa di naturale o come un fatto divino, bensì come un prodotto realizzato dagli esseri umani, e quindi suscettibile di modifiche e cambiamenti. Nell'ambito dello spazio reale, la regolamentazione dei comportamenti mediante l'architettura è in parte limitata dalle leggi fisiche. Infatti, la materia di cui il mondo è fatto è solo assai limitatamente nella nostra disponibilità. Nonostante questi limiti, nel mondo reale è possibile individuare vari fenomeni di regolamentazione mediante architettura: è il caso dei dossi artificiali o speed bump, frutto di una modifica della configurazione della pavimentazione stradale, volta a ridurre la velocità di transito dei mezzi di trasporto. Tale forma di regolamentazione risulta molto più stringente ed efficace di quanto non lo sia la previsione del Codice Strada. La presenza del dosso artificiale, infatti, non si limiterà a determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria all'automobilista indisciplinato, ma farà molto di più, in quanto provocherà il danneggiamento dell'auto che supera il limite di velocità, con la conseguenza che l'automobilista sarà costretto a terminare la sua corsa. Un ulteriore esempio di architettura dello spazio reale come mezzo di regolamentazione può essere notato osservando un'immagine della porta di ingresso della chiesa cattolica di St. Peter a Jaffa: si tratta di una porta di dimensioni estremamente ridotte, che induce chi la varca a genuflettersi. In questo caso, la "norma sociale" di carattere religioso, secondo cui i fedeli devono genuflettersi quando entrano in un luogo sacro, acquisisce forza coattiva, in quanto supportata e rafforzata dall'architettura dello spazio. Tuttavia, come asserito in precedenza, lo spazio reale è composto da una materia che solo in parte può essere "plasmata" per adattarsi alle esigenze e ai bisogni umani. Infatti, per quanto l'uomo incida sulle architetture, esistono leggi fisiche (fisse e immutabili) che regolano lo spazio, e quindi i comportamenti. Lo stesso non può dirsi con riferimento al cyberspazio, un mondo interamente artefatto, ove ogni aspetto del comportamento è regolato da istruzioni eseguite al computer. Pertanto, ogni volta che nel cyberspazio si presenterà un problema di regolamentazione, i code writer, i legislatori dello spazio virtuale, potranno modificare la struttura del mondo virtuale, allo scopo di disciplinare i comportamenti degli utenti. Per esemplificare quanto detto, consideriamo che nel mondo reale la pornografia è vietata ai bambini. Tale divieto risulta efficace grazie a certe caratteristiche riconducibili al design dello spazio reale, ove è piuttosto difficile nascondere la propria età. Chi commercia materiale pornografico riconosce facilmente i bambini, e si presume non venda a questi alcunché. L'età nello spazio reale, pertanto, è classificabile come un fatto self-authenticating. Al contrario, Rete non c'è alcun modo di stabilire la vera età dell'interlocutore, in quanto la caratteristica dell'architettura impedisce forme di auto-identificazione e interferisce con la finalità collettiva consistente nel tenere la pornografia fuori dalla portata dei bambini. Per far sì che nel cyberspazio l'identità sia self-authenticating, è necessario modificare il code Rete. Lessig è del parere che, se le tecnologie di identificazione fossero una caratteristica intrinseca della struttura Rete, la regolamentazione dei comportamenti nel cyberspazio risulterebbe più valida. Egli ipotizza i risvolti di una legge che prevedesse la produzione di browser web con il "sistema" Kids-Mode Browsing (KBM): i genitori interessati ad un controllo di questo tipo potrebbero impostare il navigatore del figlio, in modo che il server percepisca che chi sta navigando è un bambino. Un intervento di questo genere modificherebbe la regolamentazione Rete e lo farebbe, non regolando direttamente il comportamento del bambino, bensì alterando una caratteristica dell'architettura del cyberspazio. Da questo esempio emerge come l'architettura del cyberspazio sia di per sé neutra. A seconda dello scopo da raggiungere, si modificherà il code in un modo anziché in un altro. Un ultimo esempio chiarirà la suddetta affermazione: alle origini di Internet, la comunicazione avveniva mediante testi, ossia parole scritte su uno schermo. Questa modalità di comunicare era considerata da molti una limitazione, determinata dal fatto che la larghezza di banda Rete alle sue origini era molto limitata. Tuttavia, a ben pensarci, questo particolare tipo di architettura permetteva a determinate classi di persone, disabili nello spazio reale, di comunicare e di confrontarsi senza alcuna difficoltà. Il cieco poteva utilizzare programmi che leggessero i testi; il sordo riusciva a comunicare senza bisogno di sentire suoni e voci; il "brutto" poteva conversare senza essere visto, e in questo modo non si sentiva a disagio a causa del suo aspetto. L'architettura del primo cyberspazio dava a queste persone qualcosa che esse non potevano avere nello spazio reale. Essa "ribaltava" quel mix di benefici e gravami che ricadevano sui consociati nello spazio reale. Nel Web, il dotto era avvantaggiato, mentre l'attraente era svantaggiato: l'esatto opposto di quanto avveniva nel mondo reale. Questa architettura è mutata nel tempo: la grafica ha reso il cieco di nuovo "cieco"; il suono ha reso il sordo nuovamente "sordo"; le videocam delle chat room hanno reso il brutto di nuovo "brutto". L'architettura di per sé non ha né colore, né forma: tuttavia, a seconda di come viene manipolata, essa può arrivare addirittura ad incidere sulla percezione dei valori di una società. Segnala ad un amico |
- Unisciti a noi
- | Condizioni d'uso
- | Informativa privacy
- | La Redazione
- | Info
- | Pressroom
- | Contattaci
© Copyright 2025 BlazeMedia srl - P. IVA 14742231005
- Gen. pagina: 0.37 sec.
- | Utenti conn.: 77
- | Revisione 2.0.1
- | Numero query: 44
- | Tempo totale query: 0.18