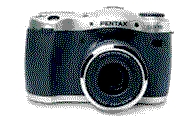 Se ne legge sempre più spesso, anche sulla stampa non specialistica; le vetrine dei negozi di informatica e di materiale fotografico espongono modelli sempre più nuovi e sofisticati; se ne vedono sempre di più al collo dei turisti.
Se ne legge sempre più spesso, anche sulla stampa non specialistica; le vetrine dei negozi di informatica e di materiale fotografico espongono modelli sempre più nuovi e sofisticati; se ne vedono sempre di più al collo dei turisti.
Parliamo delle Macchine Fotografiche Digitali, nuovo "oggetto del desiderio" del sempre più numeroso popolo del PC. Eppure, il loro costo, anche se in costante discesa, è ancora piuttosto elevato, e, fatte salve le fotocamere professionali, che costano dai 10 milioni in su, la qualità su stampa delle foto scattate con questi strumenti, non è ancora oggi paragonabile a quella ottenibile con una buona, tradizionale, e, soprattutto, meno costosa, macchina fotografica, a meno di mettere ancora mano al portafogli, per comprare l'ultimo modello di stampante dedicata alla fotografia (cartucce con inchiostri particolari, testine speciali, costo dalle 500.000 lire in su), abbinata ad una carta fotografica speciale (dalle 30.000 alle 50.000 lire per una risma da 15 - 20 fogli in formato A4). Ma gli ultimi modelli usciti sul mercato, e quelli che sono in previsione di uscire nei prossimi mesi, promettono di raggiungere le fotocamere tradizionali sulla strada della qualità fotografica, anche perché le macchine fotografiche che noi conosciamo da sempre, rappresentano un prodotto già abbondantemente maturo, e con pochi margini di miglioramento, pur con l'ausilio della elettronica più sofisticata, mentre quelle digitali hanno solo pochi anni di vita, e promettono sviluppi futuri impensabili! Staremo a vedere!
Quale è allora il segreto di un simile successo, che vede incrementi a due cifre nelle vendite di queste macchine, laddove, invece, c'è stagnazione nel mercato delle reflex e delle compatte 35 mm? E che, soprattutto, vede la discesa in campo, oltre ai principali produttori di macchine fotografiche tradizionali, come Canon, Nikon, Olympus, anche colossi dell'informatica, come Epson, HP, Sony, etc..?
Ad ognuno il suo
Le risposte, e, quindi, le motivazioni di acquisto, sono molteplici:
- La possibilità di vedere immediatamente, sul proprio monitor, o stampate su carta, le foto scattate, con un considerevole risparmio di tempo. Ciò è particolarmente utile per chi con le foto ci lavora giornalmente, come fotografi professionisti, giornalisti, architetti, arredatori, periti assicurativi, etc. Ma, a ben guardare, questo aspetto può essere interessante anche per l'utente non professionale, che, oltretutto, si risparmia anche tre viaggi dal fotografo; il primo, per comprare il classico rollino fotografico, il secondo per portargli il rullino con le foto scattate, ed il terzo per ritirare le foto agognate. Ma se andassero perse...? Può succedere, no? (non me ne vogliano gli amici fotografi!)
- La possibilità di correggere eventuali errori di ripresa (tipicamente, gli "occhi rossi" nelle foto scattate con il flash), e di elaborare le foto secondo il proprio gusto estetico, aggiungendo uno sfondo, o utilizzando una particolare dominante di colore; in ciascuno di noi, non si nasconde forse un artista? E poi, siamo sempre soddisfatti dei tradizionali laboratori di sviluppo fotografico? Quanti di questi fanno ancora opera di fotoritocco?
- La possibilità di archiviare le foto in pochissimo spazio, quello del nostro disco fisso, o, disponendo di un masterizzatore, di qualche CD. Avete mai pensato a quanto spazio occupano materialmente le centinaia, per non dire migliaia, di foto che ciascuno di noi accumula nella propria vita? Numeri e numeri di raccoglitori, di tutte le forme, di tutte le dimensioni, di tutti i colori, per non dire delle foto disseminate nei cassetti, perché non avete tempo per metterle in ordine!
- La certezza che le nostre foto non ingialliranno mai, e conserveranno sempre nel tempo i loro colori, anche a distanza di decenni, fatta salva, naturalmente, la durata del supporto fisico sul quale le abbiamo memorizzate.
- La possibilità di spedire le nostre foto via e-mail, a parenti ed amici, per condividere con loro i nostri momenti più belli, con estrema semplicità, rapidità, senza rischio di andare perdute, ed al solo costo di un collegamento Internet.
- La facilità con cui è possibile duplicare ed ingrandire le nostre foto;
- La possibilità di inserirle nei nostri documenti, o, perché no? nel nostro sito Web.
- La possibilità, per l'appassionato di fotografia, di risparmiare centinaia di migliaia di lire all'anno nell'acquisto di rullini fotografici, e nella successiva stampa presso i laboratori fotografici tradizionali, ammortizzando, nel giro di pochi anni, i soldi spesi nell'acquisto di fotocamera digitale e stampante fotografica.

E tante, tante altre motivazioni ancora, che ciascuno di noi può trovare dentro di se!
 Vediamo adesso un po' più da vicino come sono fatti questi veri gioielli della tecnologia, non lasciandoci influenzare da particolari (le piccole dimensioni, il mirino di tipo galileiano, il flash incorporato, l'obiettivo non intercambiabile) che le fanno somigliare alle "compatte" tradizionali.
Vediamo adesso un po' più da vicino come sono fatti questi veri gioielli della tecnologia, non lasciandoci influenzare da particolari (le piccole dimensioni, il mirino di tipo galileiano, il flash incorporato, l'obiettivo non intercambiabile) che le fanno somigliare alle "compatte" tradizionali.
Uno degli elementi più importanti, e più costosi, di una fotocamera digitale, è il "Sensore CCD", sul quale punta molto il battage pubblicitario (si legge, infatti, spesso, di "fotocamere digitali a 3, o a 4 megapixel"), ma sul quale spesso, volutamente, non è fatta chiarezza, a discapito del consumatore (leggi: tutti noi)
Cerchiamo di capire meglio. Il Sensore CCD (CCD = Charged Coupled Device, dispositivo ad accoppiamento di carica) è un elemento caratterizzante della fotocamera digitale (ma si trova anche nelle videocamere digitali e negli scanner), nel senso che non ha analogo nella fotocamera tradizionale, o meglio, corrisponde, in un certo senso, alla pellicola fotografica. Su di esso, infatti, va ad incidere la luce che filtra attraverso l'obiettivo, luce che, nelle fotocamere tradizionali va, invece, ad "impressionare", appunto, la pellicola.  Di forma rettangolare, e di dimensioni inferiori ai classici 24 x 36 mm delle pellicole tradizionali, ma variabili da macchina a macchina, il sensore è formato da un numero di elementi sensibili alla luce, detti "elementi CCD" o "fotodiodi", variabile da 500.000 ai 4.000.000 e passa delle fotocamere più costose (Il record, ad oggi, Gennaio 2002 è Dimage 7 di Minolta, il cui sensore è formato da ben 5.24 milioni di elementi), e che convertono gli impulsi luminosi che li colpiscono (in pratica, la luce), in impulsi elettrici, che, a loro volta, saranno poi convertiti in dati digitali. Avvicinandoci parecchio alla realtà delle cose, possiamo dire che ad ogni singolo fotodiodo corrisponde un singolo punto luminoso, detto "Pixel", della immagine, tanto che, per comodità, sono detti pixel anche i fotodiodi del sensore (si parla, infatti, di sensori da 1,2,3 Megapixel o milioni di pixel, etc). Per avere un termine di paragone, si pensi che, per convenzione, si assume che un tradizionale negativo fotografico contenga circa 6 milioni di punti, che non sono detti pixel, ma che corrispondono ai pixel delle immagini digitali. In realtà, il numero dei fotodiodi è di poco superiore a quello dei pixel che si possono visualizzare nella immagine, in quanto alcuni di questi elementi esplicano altre funzioni, ma, in linea di massima, l'equazione: tanti fotodiodi, uguale tanti pixel, è sufficientemente corretta, per cui non sbagliamo se diciamo che, più elevato è il numero di fotodiodi del sensore, e maggiore sarà la risoluzione ottica della immagine. Quindi: più grande è il sensore, più fotodiodi vi sono contenuti, più elevata è la risoluzione ottica della immagine, ma, ahinoi, più costosa è la macchina.
Di forma rettangolare, e di dimensioni inferiori ai classici 24 x 36 mm delle pellicole tradizionali, ma variabili da macchina a macchina, il sensore è formato da un numero di elementi sensibili alla luce, detti "elementi CCD" o "fotodiodi", variabile da 500.000 ai 4.000.000 e passa delle fotocamere più costose (Il record, ad oggi, Gennaio 2002 è Dimage 7 di Minolta, il cui sensore è formato da ben 5.24 milioni di elementi), e che convertono gli impulsi luminosi che li colpiscono (in pratica, la luce), in impulsi elettrici, che, a loro volta, saranno poi convertiti in dati digitali. Avvicinandoci parecchio alla realtà delle cose, possiamo dire che ad ogni singolo fotodiodo corrisponde un singolo punto luminoso, detto "Pixel", della immagine, tanto che, per comodità, sono detti pixel anche i fotodiodi del sensore (si parla, infatti, di sensori da 1,2,3 Megapixel o milioni di pixel, etc). Per avere un termine di paragone, si pensi che, per convenzione, si assume che un tradizionale negativo fotografico contenga circa 6 milioni di punti, che non sono detti pixel, ma che corrispondono ai pixel delle immagini digitali. In realtà, il numero dei fotodiodi è di poco superiore a quello dei pixel che si possono visualizzare nella immagine, in quanto alcuni di questi elementi esplicano altre funzioni, ma, in linea di massima, l'equazione: tanti fotodiodi, uguale tanti pixel, è sufficientemente corretta, per cui non sbagliamo se diciamo che, più elevato è il numero di fotodiodi del sensore, e maggiore sarà la risoluzione ottica della immagine. Quindi: più grande è il sensore, più fotodiodi vi sono contenuti, più elevata è la risoluzione ottica della immagine, ma, ahinoi, più costosa è la macchina.
Abbiamo introdotto, così, un nuovo concetto: la "Risoluzione ottica di una immagine", che possiamo definire come il grado di "ricchezza di particolari" (espresso in "numero di pixel"), con cui una immagine viene "acquisita", e che è una caratteristica intrinseca della immagine, che può essere impostata, prima ancora di scattare la nostra foto. Cioè, in tutte le fotocamere digitali è possibile scegliere a priori, e foto per foto, il numero di pixel da cui sarà formata l'immagine. Tanto più elevato è questo numero, e tanto più "ricca di dettagli", e, pertanto di migliore qualità, sarà la nostra immagine; ma dalla risoluzione, dipendono, poi, anche, le dimensioni con cui potrà essere visualizzata sul monitor o stampata, in modo soddisfacente, la nostra foto.
 Un esempio chiarirà meglio questi concetti. Supponiamo di avere una immagine con una risoluzione di 800 x 600 pixel (il primo valore si riferisce ai pixel in orizzontale, mentre il secondo, ai pixel in verticale) ; l'immagine, pertanto, sarà formata da un totale di 480.000 pixel; se la visualizziamo sul monitor, poiché i monitor, solitamente, sono in grado di visualizzare 72 punti per pollice quadrato (si dice che hanno un DPI - Dots Per Inch - di 72), (un pollice quadrato equivale ad un quadrato con un lato di 2.54 cm), questa immagine avrà dimensioni di 28.2 x 21.15 cm, e, pertanto, occuperà tutto lo schermo di un monitor da 17 pollici. Infatti 800 (i pixel della immagine): 72 (il DPI del monitor) = 11.11 pollici x 2.54 cm (a tanti cm corrisponde 1 pollice) = 28.22 cm; 600: 72 = 8.33 pollici x 2.54 cm = 21.16 cm.
Un esempio chiarirà meglio questi concetti. Supponiamo di avere una immagine con una risoluzione di 800 x 600 pixel (il primo valore si riferisce ai pixel in orizzontale, mentre il secondo, ai pixel in verticale) ; l'immagine, pertanto, sarà formata da un totale di 480.000 pixel; se la visualizziamo sul monitor, poiché i monitor, solitamente, sono in grado di visualizzare 72 punti per pollice quadrato (si dice che hanno un DPI - Dots Per Inch - di 72), (un pollice quadrato equivale ad un quadrato con un lato di 2.54 cm), questa immagine avrà dimensioni di 28.2 x 21.15 cm, e, pertanto, occuperà tutto lo schermo di un monitor da 17 pollici. Infatti 800 (i pixel della immagine): 72 (il DPI del monitor) = 11.11 pollici x 2.54 cm (a tanti cm corrisponde 1 pollice) = 28.22 cm; 600: 72 = 8.33 pollici x 2.54 cm = 21.16 cm.
Se, invece, proviamo a stamparla, ed impostiamo la nostra stampante su un DPI di 300 x 300, comunemente ritenuto adeguato per garantire una qualità fotografica accettabile, (in gergo digitale si parla di "Risoluzione di stampa alta"), otterremo una foto di 6.77 x 5,08 cm, lontana, quindi, come dimensioni, dal formato fotografico standard cui siamo abituati, e cioè, il 10 x 15 cm.
Infatti: 800 (i pixel della immagine): 300 (il DPI che abbiamo impostato nella stampante) x 2.54 cm = 6, 77 cm e 600 (i pixel della immagine): 300 (il DPI che abbiamo impostato nella stampante) x 2.54 cm = 5.08 cm.
Sacrificando la qualità, e stampando, per esempio, a 200 x 200 DPI ("Risoluzione di stampa medio-alta"), otterremo una immagine di 10 x 7.5 cm circa. In ogni caso, è meglio non scendere sotto i 150 x 150 DPI ("Risoluzione di stampa medio-bassa"), anche se l'occhio umano non è in grado di distinguere i singoli punti di una immagine quando sono più di 100 per pollice, ad una normale distanza di visione di 25 -30 cm. Ma se ci avviciniamo di più, o se usiamo una lente di ingrandimento, si, e l'immagine apparirà sgranata!
Facendo i dovuti calcoli, quindi, se vogliamo stampare nel formato tradizionale (10 x 15 cm) una foto di qualità accettabile (Ripeto, 300 DPI, risoluzione di stampa alta), abbiamo bisogno di una risoluzione di 1181 x 1772 pixel, che ci dà una foto di 2.092.732 pizel; se, invece, ci contentiamo di una risoluzione di stampa medio-alta (200 DPI), abbiamo bisogno di una risoluzione di 787 x 1781, che ci dà una foto di 1.401.647
Il conto è presto fatto: 10 (cm): 2.54 (Pollici) x 300 (Valore di DPI) = 1181, e,
15 (cm): 2.54 (Pollici) x 300 (Valore di DPI) = 1772. Seguendo questo esempio, chiunque può costruirsi delle tabelle per determinarsi, in base alla risoluzione di stampa, ed alle dimensioni della stessa, di quanti pixel ha bisogno.
Tornando al ns esempio precedente, se il nostro sensore CCD ha 2.100.000 fotodiodi, non vi è alcun problema (ma parliamo già di macchine con un costo superiore, di solito, a 1.500.000 lire), ma non vi sono grossi problemi, a patto di rinunciare un po' alla qualità, anche se la nostra fotocamera ha solo, per esempio, 1500 x 1200 pixel CCD (quindi, 1.800.000 pixel). (Da notare che, in tutti questi nostri esempi, parliamo di qualità "accettabile" della foto, lontana dalla qualità cui siamo abituati con le fotocamere tradizionali!).
 Tutte le fotocamere digitali moderne, infatti, dispongono di un software che permette di aumentare artificiosamente la risoluzione di una immagine, aggiungendo, tramite complessi calcoli matematici, un numero più o meno elevato di pixel, a discapito, ovviamente della qualità della foto, che apparirà più o meno "sgranata", in quanto questi pixel aggiunti, di fatto, non corrispondono a punti presenti realmente nella immagine originale.
Tutte le fotocamere digitali moderne, infatti, dispongono di un software che permette di aumentare artificiosamente la risoluzione di una immagine, aggiungendo, tramite complessi calcoli matematici, un numero più o meno elevato di pixel, a discapito, ovviamente della qualità della foto, che apparirà più o meno "sgranata", in quanto questi pixel aggiunti, di fatto, non corrispondono a punti presenti realmente nella immagine originale.
Abbiamo introdotto, così, il concetto di "Risoluzione Interpolata" o "Risoluzione Massima", di una fotocamera digitale, sempre maggiore, pertanto, della "Risoluzione Ottica", e sulla quale, spesso e volutamente, le case produttrici di fotocamere digitali, e rivenditori compiacenti, fanno poca chiarezza, spacciando per 2.5 megapixel, per esempio, macchine con sensore da 2 o 1.8 megapixel. È segno di serietà indicare separatamente il numero di sensori CCD, la risoluzione ottica, e la risoluzione massima.
La conclusione di tutto ciò è ovvia: andare a verificare, in vista di un acquisto (ma non è sempre facile), quale è la "Risoluzione Ottica" della macchina, cui è direttamente proporzionale la qualità effettiva della immagine.
Pur nondimeno, anche una elevata "Risoluzione Massima" può essere presa in considerazione, specie se intendiamo stampare ingrandimenti delle nostre foto, senza badare troppo alla qualità.
Da tutto quanto detto, ne consegue un importante risvolto pratico. Prima di un acquisto, è bene valutare attentamente quello che si intende fare delle proprie foto digitali.
Se l'intenzione è prevalentemente quella di limitarsi a guardarle sul PC, o metterle su Internet, allora può essere sufficiente una fotocamera con un sensore CCD da 1 - 1.5 milioni di pixel; se, invece, ci piacerebbe stamparle, dovremo rivolgere la nostra attenzione a fotocamere con sensore CCD dai 2 milioni di pixel in su, a seconda di quanto siamo disposti a spendere.
Un altro elemento molto importante nel determinare la qualità delle nostre foto, ed anche esso, pertanto, in grado di influire pesantemente sul costo dell'apparecchio, è dato dal tipo di ottica montata.
Da questo punto di vista, non ci sono grosse differenze con le fotocamere compatte tradizionali Abbiamo, pertanto, fotocamere con fuoco fisso (cioè, con un obiettivo di lunghezza focale costante, che ci costringe ad avvicinarci o ad allontanarci dal soggetto, se vogliamo, rispettivamente, ingrandirlo o rimpicciolirlo), e sono le più economiche, e fotocamere con zoom ottico, con estensione della focale dal grandangolo (28-35 mm), al medio-tele (135-300 mm), che ci permettono di ingrandire o rimpicciolire il soggetto a nostro piacimento, senza bisogno di spostarci dalla nostra posizione, ma semplicemente agendo sull'obiettivo, e sono le più costose.
 Quasi tutte, sono, poi Autofocus, nel senso che sono in grado di mettere automaticamente a fuoco il soggetto, ciò che è particolarmente utile per riprendere soggetti in movimento, e con ottica non intercambiabile; la possibilità di cambiare obiettivo, infatti, è riservata alle fotocamere professionali.
Quasi tutte, sono, poi Autofocus, nel senso che sono in grado di mettere automaticamente a fuoco il soggetto, ciò che è particolarmente utile per riprendere soggetti in movimento, e con ottica non intercambiabile; la possibilità di cambiare obiettivo, infatti, è riservata alle fotocamere professionali.
Non ci soffermeremo su termini come lunghezza focale di un obiettivo, grandangolo, teleobiettivo, autofocus, sensibilità ISO (si, c'è anche questa, nelle fotocamere più sofisticate, anche se, più correttamente, si dovrebbe parlare di "ISO Equivalenza", dato che la sensibilità ISO è una caratteristica intrinseca della classica pellicola fotografica, e, appunto, nelle fotocamere digitali, come visto, non vi è uso di pellicole. Semplificando al massimo la possiamo definire come la "sensibilità alla luce" del sensore CCD, ed è un indice della qualità del sensore stesso, tenendo presente che una sensibilità ISO non modificabile dall'utente è tipica delle fotocamere più economiche, ed è pari a 100 ISO, mentre nelle fotocamere più costose, il valore ISO può essere modificato, e va da un minimo di 100 ad un massimo di 400, per raggiungere i 1.600 ISO nelle fotocamere professionali), tempi di otturazione, aperture minime dei diaframmi, profondità di campo, perché ci condurrebbe troppo in là, ed esulerebbe dallo scopo di questa nostra chiacchierata; ma chi fosse interessato al significato di questi termini, che sono condivisi dalla fotografia classica, e che, comunque, ogni appassionato di fotografia, digitale o tradizionale, conosce, può benissimo rivolgersi ad uno qualsiasi della miriade di libri sulla fotografia. Se invece, vi interessa solo scattare le foto, e basta, potete anche fare a meno di conoscere il significato dei termini succitati. Comunque, nel glossario, verrà riportata una spiegazione molto semplice di questi termini.
Ci preme, qui, a proposito degli obiettivi, sottolineare, ancora, due aspetti:
- Molte fotocamere dispongono, anche, o solo, di uno Zoom Digitale, che opera interpolando, con complesse operazioni matematiche, i dati mancanti, ed offrendo, pertanto, risultati inferiori a quelli dello Zoom Ottico. In pratica, lo zoom digitale, di solito, si limita ad ingrandire l'immagine, senza aggiungere una maggiore quantità di dettagli, ma, anzi, sgranandola. Praticamente, se mediante uno zoom digitale di 2.5 x acquisiamo una immagine a 1600 x 1200 pixel, la nostra foto avrà una ricchezza di dettagli simile a quella di una foto scattata ad una risoluzione ottica di 640 x 480 pixel, con una riproduzione ottimale, in fase di stampa, solo nel formato 5.4 x 4 cm! Quindi, anche in questo caso, quando vi si parla di Zoom, chiedere sempre se si tratta di Zoom ottico, o di Zoom digitale, perché, come avrete capito, anche qui ci può essere l'equivoco.
- Quando si parla di lunghezza focale degli obiettivi delle fotocamere digitali, questa viene sempre riferita al formato fotografico tradizionale, quello delle 35 mm. Questo perché, mentre nelle macchine fotografiche tradizionali l'area su cui si forma l'immagine è sempre di 24 x 36 mm (queste, infatti, sono le dimensioni standard dei singoli fotogrammi dei rollini fotografici), nelle fotocamere digitali, le dimensioni del sensore CCD sono sempre più piccole rispetto a quelle della normale pellicola, per cui, per ottenere lo stesso angolo di visuale di una macchina fotografica tradizionale, anche la lunghezza focale dell'obiettivo dovrà essere inferiore in misura proporzionale. In pratica, se il sensore CCD ha una superficie che è 1/3 di quella della pellicola fotografica, e cioè, 8 x 12 mm, anche l'obiettivo standard avrà una lunghezza focale pari ad 1/3 di 50 mm e cioè, di 17 mm, che, nella fotografia tradizionale corrisponde, invece, alla lunghezza focale di un buon grand'angolare. (50 mm è l'obiettivo considerato standard nella fotografia tradizionale, perché è quello la cui lunghezza focale si avvicina alla diagonale del fotogramma. In realtà, nel formato 135, la diagonale del fotogramma 24 x 36 è di 43 mm, ma l'obiettivo considerato standard ha una lunghezza focale, appunto, di 50 mm, perché il suo angolo di campo, e cioè, la parte di spazio che riesce a ritrarre, che è di circa 45°, è praticamente uguale a quella dell'occhio umano, ed il tipo di immagine che esso forma è, pertanto, molto simile a come noi vediamo la realtà).
Inoltre, le diverse fotomacchine digitali, hanno sensori CCD di dimensioni diverse, per cui sarebbe impossibile paragonare tra di loro obiettivi di marche e modelli diversi.
Equiparando la lunghezza focale degli obiettivi di queste macchine a quella delle 35 mm, si evita, pertanto, confusione, e si può capire, così, immediatamente, di che tipo di obiettivo si tratta: standard (50 mm), grandangolare medio (35 mm), grandangolare vero (28 e 24 mm), grandangolare spinto (da 21 mm in giù), lungo fuoco o telino (da 80 a 120 mm), medio tele (da 135 a 300 mm), teleobiettivo (dai 300 mm in su).
 Un altro elemento da non sottovalutare nella scelta di una fotocamera digitale, e che incide anche esso, non poco, sul costo finale, è la "Scheda di memoria", o "memory card" capace di condizionare l'uso che facciamo della fotocamera, nel senso che da essa dipende il numero di foto che è possibile scattare senza doverla "scaricare" sul PC, o cambiarla.
Un altro elemento da non sottovalutare nella scelta di una fotocamera digitale, e che incide anche esso, non poco, sul costo finale, è la "Scheda di memoria", o "memory card" capace di condizionare l'uso che facciamo della fotocamera, nel senso che da essa dipende il numero di foto che è possibile scattare senza doverla "scaricare" sul PC, o cambiarla.
Si tratta del corrispettivo digitale del tradizionale rullino fotografico. In essa, infatti si registrano le immagini, è estraibile (tranne che in alcuni dei modelli più economici) e ve ne sono, fondamentalmente, di due tipi: le Compact Flash (più diffuse, più affidabili, ma più costose, che possono arrivare a contenere, nel tipo II, a tutt'oggi, anche 512 MB di immagini), e le Smart Media (più sottili, appena 0.5 mm, più delicate, meno costose, ma anche meno Memory Stickcapienti; oggi, fino ad un massimo di 128 MB).
 Le fotocamere Sony hanno un altro tipo di scheda, detto Memory Stick, molto sottile, molto piccola, ma, anche poco capiente, che può essere utilizzata anche nei lettori MP3. Ci sono, poi, anche i dischi Click Iomega, a costi di solito inferiori rispetto a quelli delle schede "originali"; l'ID Photo, un dischetto ottico-magnetico che può arrivare a contenere fino a 700 MB di foto, ma che, pur essendo stato messo a punto da un consorzio di colossi informatici (Hitachi, Olympus, Sanyo), è pochissimo diffuso; le Multimedia Card, usate anche per i cellulari, ed infine, i dischi Microdrive IBM, oggi arrivati alla capienza di ben 1 GB, piuttosto costosi (più di 1 milione di lire), ma capaci di memorizzare, come intuibile, una grandissima quantità di foto: quasi 800 ad una risoluzione di 1280x 1024 pixel!
Le fotocamere Sony hanno un altro tipo di scheda, detto Memory Stick, molto sottile, molto piccola, ma, anche poco capiente, che può essere utilizzata anche nei lettori MP3. Ci sono, poi, anche i dischi Click Iomega, a costi di solito inferiori rispetto a quelli delle schede "originali"; l'ID Photo, un dischetto ottico-magnetico che può arrivare a contenere fino a 700 MB di foto, ma che, pur essendo stato messo a punto da un consorzio di colossi informatici (Hitachi, Olympus, Sanyo), è pochissimo diffuso; le Multimedia Card, usate anche per i cellulari, ed infine, i dischi Microdrive IBM, oggi arrivati alla capienza di ben 1 GB, piuttosto costosi (più di 1 milione di lire), ma capaci di memorizzare, come intuibile, una grandissima quantità di foto: quasi 800 ad una risoluzione di 1280x 1024 pixel!
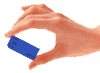
Recentemente, Sony, ha avuto una idea tanto semplice, quanto geniale, che sicuramente verrà ripresa da altri costruttori. Invece di usare le suddette schede di memoria, in genere poco capienti, e, soprattutto costose (diverse centinaia di migliaia di lire), utilizzare dei mini CD (8 cm di diametro), ovviamente riscrivibili, che possono contenere quasi 200 MB di immagini, e che costano poche migliaia di lire. La strada è aperta, e sicuramente ne vedremo delle belle!
In linea di massima, la capacità di tutti i tipi di memory card sta crescendo, parallelamente alla riduzione dei costi. Dalla scheda, l'immagine verrà poi scaricata sul disco fisso del PC, e sarà pronta per altre immagini. La maggior parte delle fotocamere oggi in commercio, dispone di schede, Smart, o Compact, da 8 - 16 MB, capaci di contenere da 2 a 6 foto scattate alla massima risoluzione; decisamente troppo poche, e tali da costringerci, quasi inevitabilmente, ad acquistare almeno un'altra scheda a parte.

 Un altro elemento della fotocamera da non sottovalutare è il tipo di collegamento al PC, che, col crescere continuo delle risoluzioni, e, quindi, delle dimensioni, in termini di kB, delle immagini digitali, è diventato un elemento sempre più importante da tenere presente. Le classiche porte, seriale e parallela, con la loro velocità di trasferimento dati, di rispettivamente, 15 e 115 kB/secondo, oggi possono andare bene solo per gli apparecchi che riproducono immagini a bassa risoluzione, ed infatti, quasi tutte le macchine più moderne, e quelle in grado di raggiungere valori anche solo medi di risoluzione, possiedono anche, o solo, la porta USB, molto più veloce (può trasferire fino a 12 M di dati per secondo), e molto più pratica, dato che le periferiche USB possono essere collegate e scollegate "a caldo", e cioè, senza dovere spegnere e riaccendere il PC. L'ideale sarebbe disporre di una interfaccia IEEE 1394 (o FireWire), velocissima, capace di trasferire fino a 400 MB di dati al secondo, ma ancora piuttosto costosa, tanto da trovarla solo in fotocamere professionali e semiprofessionali dal costo piuttosto elevato. Recentemente sono state immesse sul mercato stampanti che dispongono di un lettore di memory card, che ci permette di stampare direttamente le ns foto, senza bisogno del PC (ma in questo caso non possiamo rielaborarle, e poi, di solito, stampante e macchina fotografica devono essere della stessa marca), e fotocamere che utilizzano la porta a raggi infrarossi (IrDA), sia per scaricare la memory card sul disco fisso del PC, sia per comunicare direttamente con la stampante (anche in questo caso, di solito, della stessa marca della fotocamera). Va anche detto, per chi vuole evitare l'uso di cavi, che esistono in commercio diversi lettori di schede di memoria, che si applicano al PC, e nei quali vanno inserite le memory card una volta tolte dalla fotocamera; soluzione, questa, ideale, per esempio, per chi possedesse una fotocamera non proprio modernissima, con la sola porta seriale, ma un PC con porte USB, dato che questi lettori si inseriscono in una porta USB del PC.
Un altro elemento della fotocamera da non sottovalutare è il tipo di collegamento al PC, che, col crescere continuo delle risoluzioni, e, quindi, delle dimensioni, in termini di kB, delle immagini digitali, è diventato un elemento sempre più importante da tenere presente. Le classiche porte, seriale e parallela, con la loro velocità di trasferimento dati, di rispettivamente, 15 e 115 kB/secondo, oggi possono andare bene solo per gli apparecchi che riproducono immagini a bassa risoluzione, ed infatti, quasi tutte le macchine più moderne, e quelle in grado di raggiungere valori anche solo medi di risoluzione, possiedono anche, o solo, la porta USB, molto più veloce (può trasferire fino a 12 M di dati per secondo), e molto più pratica, dato che le periferiche USB possono essere collegate e scollegate "a caldo", e cioè, senza dovere spegnere e riaccendere il PC. L'ideale sarebbe disporre di una interfaccia IEEE 1394 (o FireWire), velocissima, capace di trasferire fino a 400 MB di dati al secondo, ma ancora piuttosto costosa, tanto da trovarla solo in fotocamere professionali e semiprofessionali dal costo piuttosto elevato. Recentemente sono state immesse sul mercato stampanti che dispongono di un lettore di memory card, che ci permette di stampare direttamente le ns foto, senza bisogno del PC (ma in questo caso non possiamo rielaborarle, e poi, di solito, stampante e macchina fotografica devono essere della stessa marca), e fotocamere che utilizzano la porta a raggi infrarossi (IrDA), sia per scaricare la memory card sul disco fisso del PC, sia per comunicare direttamente con la stampante (anche in questo caso, di solito, della stessa marca della fotocamera). Va anche detto, per chi vuole evitare l'uso di cavi, che esistono in commercio diversi lettori di schede di memoria, che si applicano al PC, e nei quali vanno inserite le memory card una volta tolte dalla fotocamera; soluzione, questa, ideale, per esempio, per chi possedesse una fotocamera non proprio modernissima, con la sola porta seriale, ma un PC con porte USB, dato che questi lettori si inseriscono in una porta USB del PC.
Come ti alimenti?
Le fotocamere digitali, così come quelle tradizionali, si alimentano con pile, che possono essere ricaricabili, o usa e getta. Quelle ricaricabili, possono essere:
- agli ioni di litio, che garantiscono maggiore autonomia, elevata velocità di ricarica, e che, infatti, si trovano nelle fotocamere più costose
- del tipo Ni-MH (Nichel ed idruri metallici), che sono lente nella ricarica, ed hanno un moderato "effetto memoria"
- Al Ni-CD (Nichel-Cadmio), che si ricaricano velocemente, che sono le meno costose, ma ancora piuttosto ingombranti, e con uno spiccato "effetto memoria", nel senso che riducono progressivamente le loro prestazioni se vengono ricaricate prima di essere del tutto scariche.
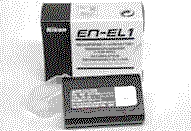 Come si vede, sono le stesse pile ricaricabili che si trovano nei cellulari.
Come si vede, sono le stesse pile ricaricabili che si trovano nei cellulari.
In alcuni modelli, invece, si usano normali pile stilo, usa e getta, ma sono, in genere, le fotocamere più economiche. La soluzione ottimale, sarebbe quella di potere montare sia le ricaricabili, sia le usa e getta, ma, purtroppo, non sono molte le fotocamere in commercio con questa caratteristica, che rappresenta il massimo della flessibilità. In ogni caso, è bene tenere presente la grande quantità di energia che queste fotocamere consumano, specie se si fa un uso frequente del display a cristalli liquidi, per cui il rischio di restare senza alimentazione sul più bello, è reale, tanto da consigliare l'acquisto separato di una batteria di scorta, sempre carica. Questo problema non esiste se si opera in interni, dato che quasi tutte le fotocamere possono essere alimentate direttamente dalla rete di casa.
Funzione video:
molte fotocamere digitali sono dotate di una uscita di tipo video, che ci permette di collegarle ad un normale video registratore, o ad un normale televisore, con la possibilità, quindi, di scaricare le immagini su normali videocassette;
Bilanciamento del bianco
, automatico o manuale: quando si fotografa in interni, con le luci artificiali, o in esterni, in particolari condizioni di illuminazione naturale, le foto assumono delle fastidiose dominanti di colori, che possono essere eliminate, restituendo alla foto i suoi colori originali, con questa funzione, che, se regolata manualmente, è più efficace.
Schermo a colori a cristalli liquidi (LCD)
, detto anche visore, o monitor, o display: di dimensioni variabili (la diagonale è compresa, di solito, tra 1.6 e 2.2 pollici), e posto, solitamente, sul retro della macchina, non ha un corrispettivo nelle fotocamere tradizionali. Può fungere anche da mirino, per controllare la inquadratura, può servire per visualizzare i menu di controllo dei vari automatismi della macchina, ma la sua funzione più interessante è quella di permetterci di vedere subito le foto appena scattate, in modo da eventualmente eliminare quelle che non ci piacciono, e liberare così spazio prezioso dalla scheda di memoria. Tuttavia, il pannello LCD consuma parecchio le batterie, e di questo bisogna tenere conto, specie se non si dispone di batterie di riserva, e non è facilmente visibile in condizioni di forte luminosità, per cui sono preferibili le macchine con display e mirino ben distinti rispetto a quelle con il solo display, anche perché, disponendo di entrambi, si può utilizzare il mirino per fotografare soggetti lontani, ed il display per soggetti molto vicini, laddove il mirino ottico risente dell'errore di parallasse (quel classico inconveniente delle fotocamere tradizionali compatte, cioè, non reflex, per cui, specie nelle foto ravvicinate, si vede una cosa e se ne fotografa un'altra). Il display, infatti, permette di trasformare la nostra macchina in una reflex, dato che su di esso appare proprio ciò che inquadra l'obiettivo, come nelle classiche reflex;
Compressione delle immagini:
con questa funzione, è possibile scegliere, ancora prima di scattare la foto, il grado di compressione della immagine, di solito effettuata nel formato .JPEG, e dalla quale dipende la qualità della immagine. Infatti, più si comprimono le immagini, più dettagli si perdono, specie a forti ingrandimenti, ma, per contro, si ottengono dei file meno voluminosi. Le foto, infatti, se non compresse, occupano grandi quantità di memoria; basti pensare che una foto non compressa, con una risoluzione di 640 x 480 pixel, e con una profondità di colore di 24 bit, corrispondente a 16 milioni di colori, occupa quasi 1 MB di memoria (infatti: 640 x 480 x 24 = 7.372.800 bit = 921,600 kB). In pratica, l'utente, in questo modo, in base alla quantità di spazio libero nella scheda memoria, in base al numero di foto che decide di scattare nella stessa seduta, in base all'uso che intende fare delle foto, può decidere se privilegiare la qualità delle immagini, usando un basso rapporto di compressione, ed avendo, per contro, dei file piuttosto ingombranti, o la quantità delle immagini, usando un alto rapporto di compressione, ed ottenendo, pertanto, delle foto di qualità inferiore, ma anche di un minore ingombro in termini di kB.
Minore o maggiore numero di automatismi:
tutte le fotocamere dispongono di un certo numero di impostazioni automatizzate: per il Ritratto, per i Paesaggi, per la ripresa di avvenimenti sportivi, per la ripresa notturna, ecc. Alcuni modelli hanno uno " Stabilizzatore di immagini", utile affinché le foto non vengano "mosse", specie se si usa una focale lunga; altri, possiedono, la "funzione Unione Guidata", detta anche Panorama, che permette di unire diverse foto insieme, in modo da ottenere una sola immagine panoramica (strettamente legata a questa funzione è l'idea di Epson di commercializzare una carta fotografica la cui larghezza massima è quella standard del formato A4, mentre la lunghezza è il doppio del formato A4, e cioè, quasi 60 cm. In questo modo potremo stampare delle foto panoramiche tipo poster). Contrariamente a quanto si possa pensare, solo le fotocamere più economiche dispongono solamente di un automatismo totale nella scelta della corretta esposizione della foto, nel senso che non lasciano, all'operatore, alcuna possibilità di scegliere né i tempi di esposizione, né l'apertura del diaframma. Infatti, sono solo le fotocamere più costose che permettono queste scelte, dando la possibilità, all'operatore, di liberare la propria creatività, privilegiando, a seconda del risultato finale che si vuole ottenere, il grado di apertura del diaframma (priorità di diaframmi), o il tempo di esposizione (priorità di tempi), o, infine, lasciando fare tutto alla macchina. Proprio come nelle migliori reflex tradizionali! Solo le professionali, infine, permettono una fotografia digitale completamente manuale, nel senso che lasciano all'operatore il piacere di scegliere l'accoppiata apertura di diaframma-tempo di esposizione che più gli aggrada. Purtroppo, in quasi tutti i modelli, queste impostazioni possono essere fatte solo dal monitor LCD, ciò che porta ad un fastidioso consumo delle batterie; sono molto poche, infatti, le fotocamere digitali che hanno sul corpo macchina i comandi necessari per regolare le suddette impostazioni.
Possibilità, o meno, di montare un flash esterno
, dato che quello incorporato nella fotocamera, ha, di solito, una bassa potenza luminosa, che si spinge fino a 3 massimo 4 metri di distanza.
Funzione Macro
, per fotografare a brevissima distanza (pochi cm) ;
Registrare messaggi vocali
, da associare alle foto;
#Registrare brevi filmati;
Lo scatto continuo
, cioè, la possibilità di scattare più fotogrammi al secondo, utile per riprendere soggetti in movimento. Il numero di scatti che è possibile effettuare dipende, ovviamente, dal modello di fotocamera, e dalla risoluzione scelta (più è elevata, e minore sarà il numero di fotogrammi al secondo che si possono scattare).
Un numero più o meno elevato di accessori:
Il mirino a correzione diottrica, per chi ha problemi di vista; la possibilità di scattare foto a distanza mediante telecomando; la possibilità di ruotare l'obiettivo o lo schermo LCD; la possibilità di montare filtri sull'obiettivo, per ottenere effetti particolari, la possibilità di utilizzare delle custodie impermeabili, che trasformano la macchina in una subacquea, ecc.
Infine, tutte le fotocamere digitali dispongono, a corredo, di un software
, più o meno sofisticato, di fotoritocco, che ci permette sia di migliorare la qualità della immagine, sia di elaborarla secondo il nostro gusto personale. Di solito si tratta di Adobe Photoshop (probabilmente, il migliore, ma, anche, il più costoso ed il più difficile da utilizzare), o Paint Shop Pro, o Photodeluxe, o Ulead Photoexpress.
 Per concludere, le fotocamere digitali compatte sono dei veri gioielli della tecnologia, in grado di regalare grandi soddisfazioni a tutti, anche a chi ha poca pratica con la fotografia; hanno un costo variabile dalle 500.000 lire ai 3 milioni e passa, si rivolgono ad un pubblico vastissimo ed eterogeneo, che va dal dilettante al semi-professionista, ed il loro mercato è in continua crescita, a tutto vantaggio del consumatore, che può disporre di modelli sempre nuovi, e con un numero sempre crescente di funzioni e/o di accessori. Anzi, sembra proprio, ultimamente, che la battaglia tra le case costruttrici si stia spostando dal numero di pixel del sensore CCD, al numero di funzioni ed accessori a disposizione dell'utente. Va da sé che, per ottenere i migliori risultati, queste fotocamere vanno sempre associate all'uso di stampanti specializzate nella stampa fotografica, ed a supporti cartacei adeguati.
Per concludere, le fotocamere digitali compatte sono dei veri gioielli della tecnologia, in grado di regalare grandi soddisfazioni a tutti, anche a chi ha poca pratica con la fotografia; hanno un costo variabile dalle 500.000 lire ai 3 milioni e passa, si rivolgono ad un pubblico vastissimo ed eterogeneo, che va dal dilettante al semi-professionista, ed il loro mercato è in continua crescita, a tutto vantaggio del consumatore, che può disporre di modelli sempre nuovi, e con un numero sempre crescente di funzioni e/o di accessori. Anzi, sembra proprio, ultimamente, che la battaglia tra le case costruttrici si stia spostando dal numero di pixel del sensore CCD, al numero di funzioni ed accessori a disposizione dell'utente. Va da sé che, per ottenere i migliori risultati, queste fotocamere vanno sempre associate all'uso di stampanti specializzate nella stampa fotografica, ed a supporti cartacei adeguati.
MegaLab.it rispetta la tua privacy. Per esercitare i tuoi diritti scrivi a: privacy@megalab.it .
Copyright 2008 MegaLab.it - Tutti i diritti sono riservati
